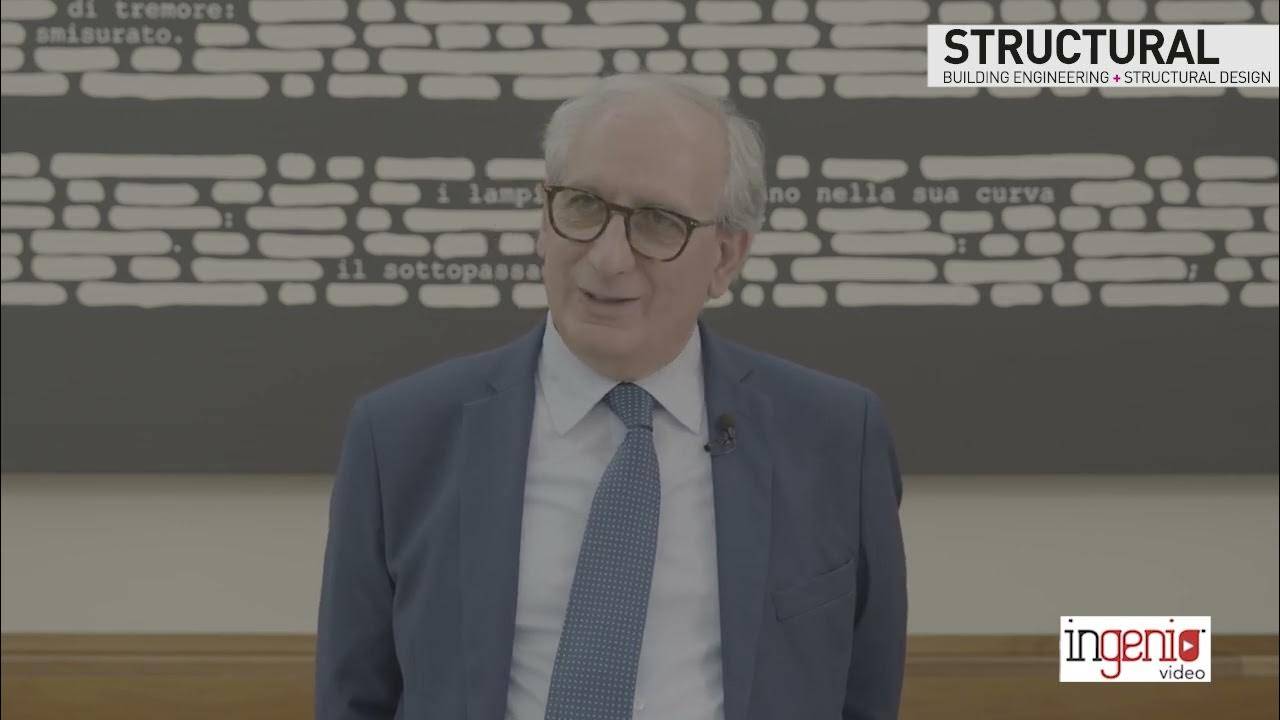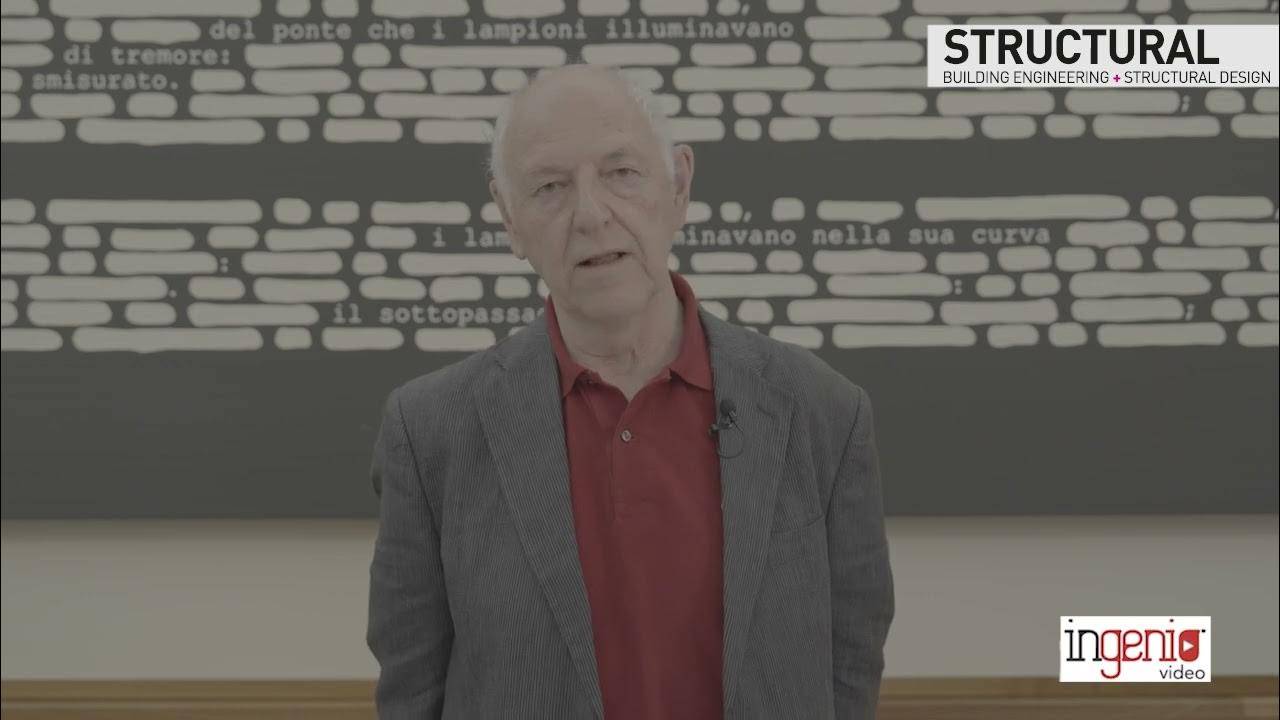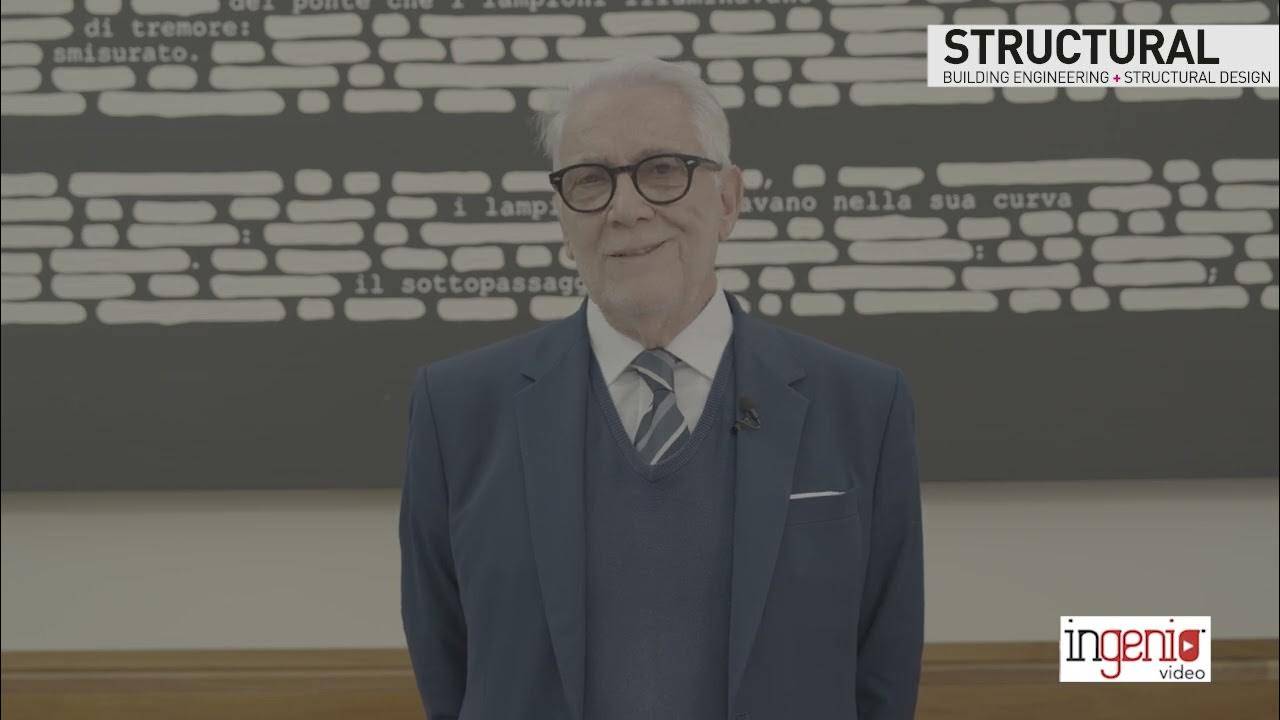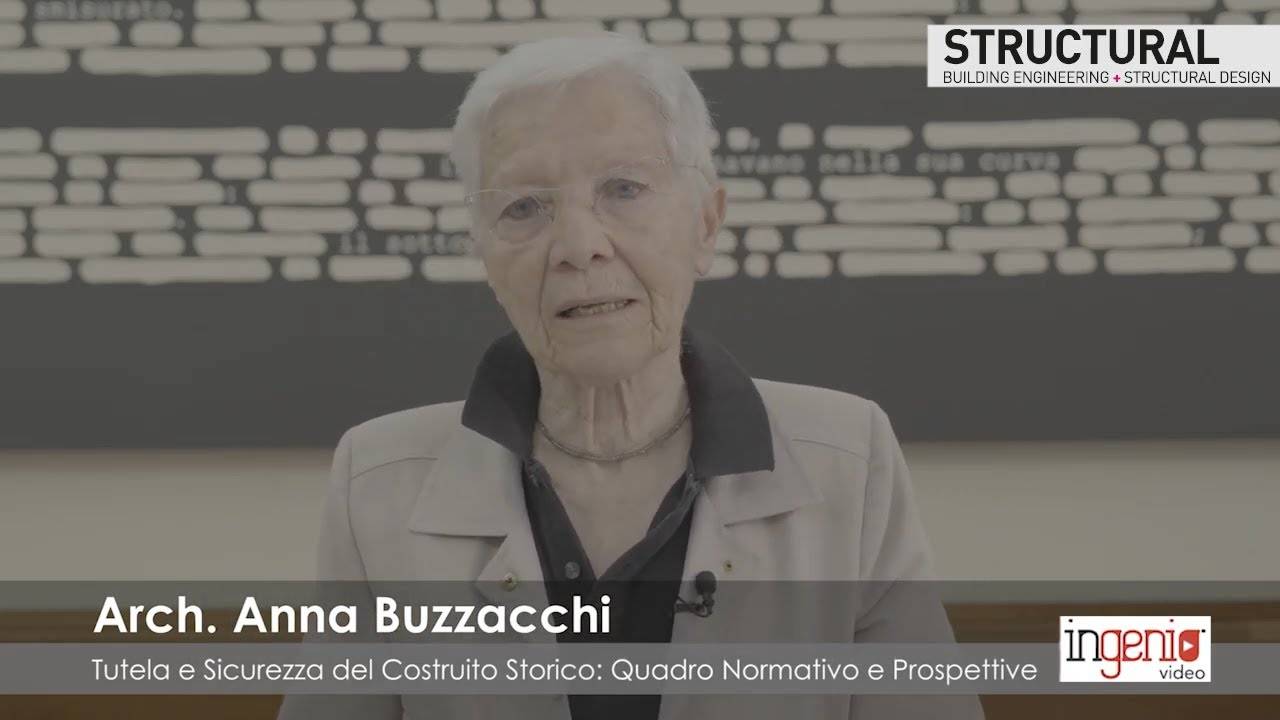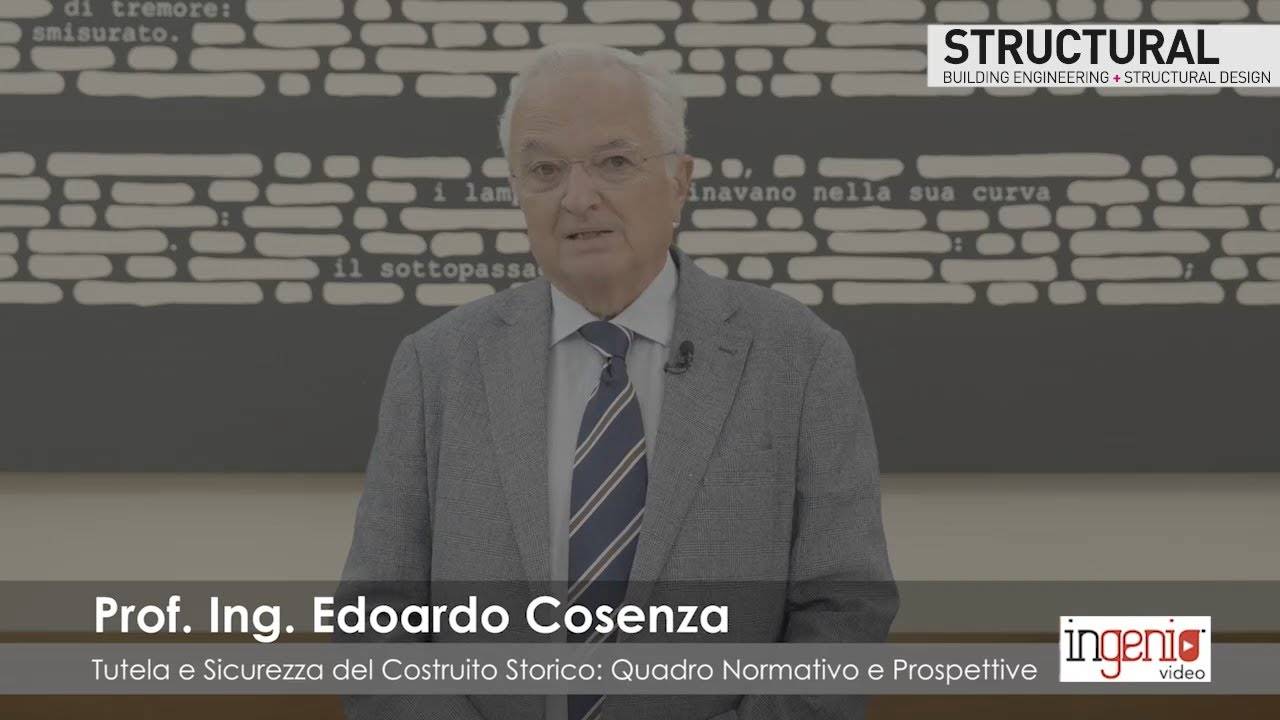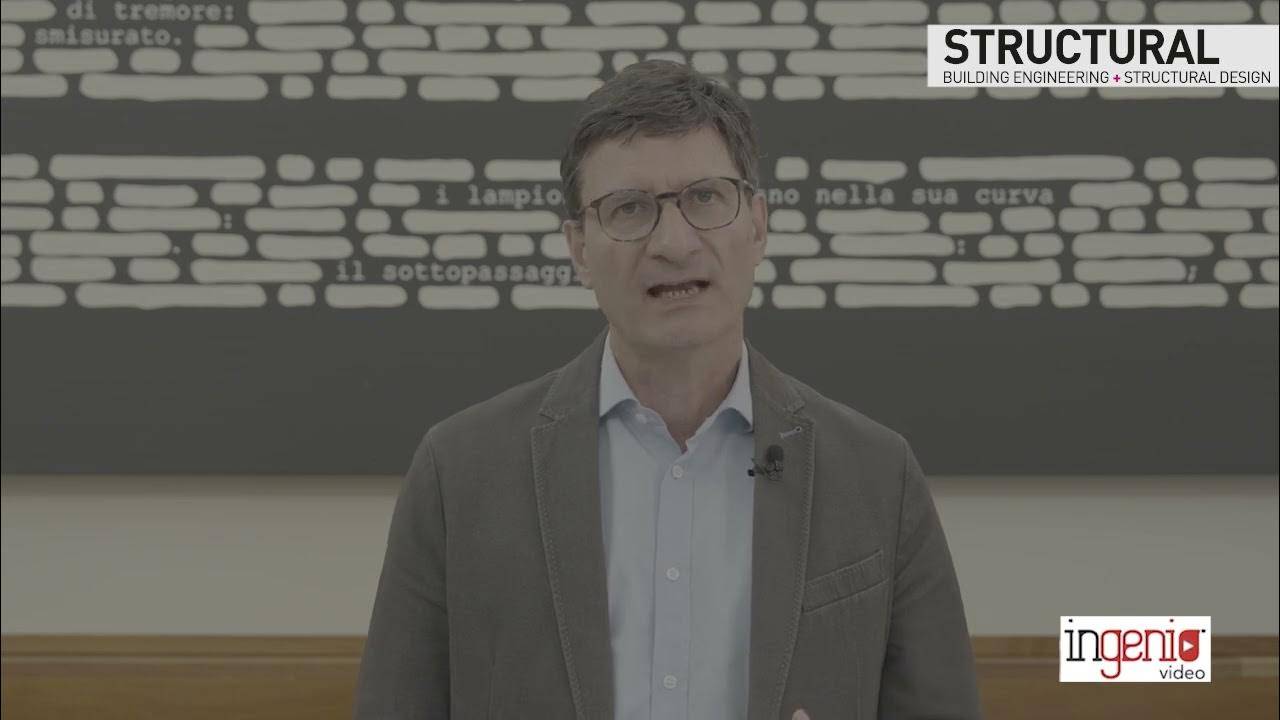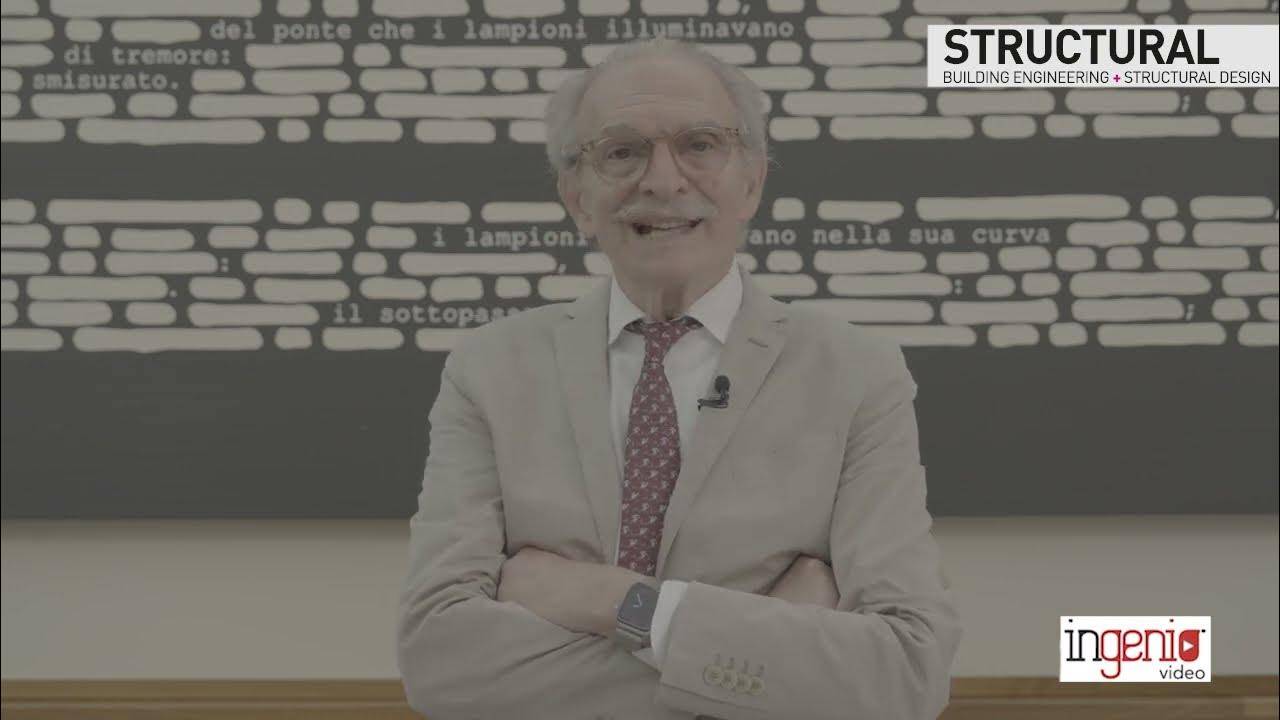Come garantire la sicurezza degli edifici storici: sfide e soluzioni nel quadro normativo attuale
La tutela degli edifici storici richiede un equilibrio tra conservazione del patrimonio e sicurezza strutturale, come discusso nel convegno organizzato da ATE, CNI, CNAPPC. È emersa la necessità di una normativa chiara e flessibile e di una collaborazione multidisciplinare per garantire la sicurezza delle persone e la protezione del patrimonio culturale.
Focus sul quadro normativo e quello costruttivo dei beni storici
Il recente incontro organizzato da ATE - Associazione Tecnologi per l'Edilizia - in collaborazione con CNAPPC e CNI, presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a Roma il 4 giugno 2024 ha offerto una piattaforma interdisciplinare per discutere le sfide e le prospettive nella gestione del patrimonio storico costruito, particolarmente sotto il profilo della sicurezza strutturale e della conservazione.
Questo evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui ingegneri e architetti, tutti impegnati a delineare un percorso più integrato e meno divisivo per l'approccio alla sicurezza degli edifici storici.
A introdurre e moderare l’evento l’ing. Donatella Guzzoni, socia fondatrice di ATE, nonché direttore della rivista Structural, che è stata l’ideatrice dell’evento. L'ing. Andrea Dari, editore di Ingenio, ha invece coordinato il dibattito finale.
Apertura dell’evento e contestualizzazione del tema
L'evento è stato inaugurato dall'ing. Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), che ha posto l'accento sull'importanza di superare le rigidità normative e di considerare le specificità dei materiali nonché le trasformazioni subite dagli edifici storici nel tempo.
Nel rievocare la storica funzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di cui quest'anno si celebrano i 165 anni dalla fondazione, avvenuta con la legge del 20 novembre 1859, n. 3574, ha evidenziato che proprio nel sito dove si svolge l'evento, si riunisce l'Assemblea generale del Consiglio Superiore, l'organo preposto a deliberare sugli affari delegati dal Presidente del Consiglio Superiore. Un organo multidisciplinare, caratteristica necessaria data la complessità delle materie che riguardano le costruzioni.
Peculiarità che vale ancor più per la sicurezza delle opere di significativo valore storico e culturale.
Ecco perché durante la predisposizione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, la problematica della sicurezza degli edifici storici era stata sollevata, ma il Ministero dei Beni Culturali si era fermamente opposto a rivedere la sua posizione, lasciando la questione irrisolta a livello normativo.

È per questa ragione che il Consiglio Superiore dei LLPP, sotto la sua presidenza, aveva intrapreso, insieme al Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, la redazione di una linea guida sugli interventi strutturali che fu interrotta a seguito del cambio di direzione al MIT.
Evidenzia il suo impegno ad operare perché possa essere ripresa.
Questa tematica è di estrema attualità. L'Ing. Sessa ha richiamato l'attenzione sulla significativa esperienza della basilica di San Benedetto di Norcia e di altre chiese crollate a seguito del terremoto del 30 ottobre 2016, mostrando come, al contrario, gli edifici residenziali privati abbiano manifestato una resilienza superiore.
È per questa ragione che l'evento assume un'importanza cruciale.
La necessità di avvicinare posizioni distanti che oggi ostacolano la soluzione per la sicurezza degli edifici storici richiede un'attenzione particolare: superare le norme, le divisioni e gli integralismi, considerando l'invecchiamento dei materiali e le trasformazioni subite nel tempo, è essenziale per affrontare efficacemente una questione di tale complessità.
L'Ing. Sessa ha quindi espresso soddisfazione per ospitare l'incontro, estendendo i suoi ringraziamenti all'Ing. Donatella Guzzoni per l'organizzazione dell'evento.

Le Sfide per le professioni
L’ ing. Alberto Romagnoli e l’arch. Massimo Crusi hanno contribuito al dibattito sottolineando le difficoltà incontrate nei percorsi normativi esistenti, spesso obsoleti e poco flessibili rispetto alle esigenze del patrimonio storico vincolato. La discussione ha messo in luce la necessità di un dialogo continuo tra i professionisti e le autorità per aggiornare e rendere più efficaci le normative vigenti.
In particolare Alberto Romagnoli, Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega alla comunicazione, ha ricordato l'impegno pluriennale del CNI e ha sottolineato come, al tempo della creazione degli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, l'Italia non fosse classificata sismicamente e mancassero norme per le strutture antisismiche. Oggi, l'approccio alla tutela dei beni deve essere integrato e coordinato, combinando estetica, conservazione strutturale e risposta a sollecitazioni statiche e dinamiche.
Ha enfatizzato che la protezione dei beni culturali richiede una collaborazione paritetica tra ingegneri e architetti, senza sudditanze professionali, e che il ruolo di coordinatore del progetto dovrebbe spettare al professionista più capace di gestire competenze diverse.
Alle parole di Romagnoli ha fatto eco il Presidente del CNAPPC Massimo Crusi che ha detto che “le professioni coinvolte devono lavorare assieme per ricostruire la storia e le necessità di un bene storico”.
Perché questo evento
L’ing. Donatella Guzzoni ha introdotto la giornata raccontando le circostanze che hanno generato questo incontro. Tutto è iniziato da una mail ricevuta dal prof. Carlo Blasi nel novembre 2023, che sottoponeva al mondo dell’ingegneria e dell’architettura un “Appello al Ministro della Cultura per una revisione delle norme che regolano la stabilità strutturale degli edifici tutelati, con riferimento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, -Codice dei beni culturali e del paesaggio”; attorno a questo testo tra alcuni colleghi, ingegneri e architetti si è sviluppato un confronto online, e una serrata discussione circa la necessità di riflettere su rapporto tra l’istanza della tutela e le istanze che attengono al rischio, alla valutazione della sicurezza e agli esiti del processo progettuale degli edifici sottoposti a vincolo secondo il D.Leg. 42 del 2004.
Si decide a marzo di organizzare un convegno in webinar. Durante tale organizzazione, dove era stato coinvolto anche il Presidente Sessa, fu proprio il Presidente che avanzò l’invito ad ospitare un tale incontro presso la Sala del Parlamentino. Grazie a questa opportunità, alla presenza del MIC e del MIT in una sede così prestigiosa, la giornata di lavoro si è trasformata in una occasione davvero centrale in un dibattito che da molto tempo si svolge nelle diverse sedi.
L'ingegner Guzzoni Introduce poi i relatori sottolineando che le diverse opinioni portate in questa sede, anche quando non allineate, e sorrette da visioni diverse, concordano tutti sul fatto che in edifici dove forma, estetica, tecnologia e storia si fondono in maniera indissolubile non si può separare la conservazione dalla sicurezza. Come poi si possa raggiungere tale obiettivo è difficile, la Normativa oggi non aiuta.
E, proprio per questo, è forse è arrivato il momento, evidenziato anche dal Presidente Sessa in apertura, di riprendere quel processo di revisione della Direttiva del 2011 fermo all’ ”Atto di Indirizzo” della Commissione mista MiC-MiT del marzo 2018.
Sarebbe anche auspicabile, o forse assolutamente necessario, che si avvii un processo di armonizzazione tra le due Leggi quadro, di primo livello, il D.Lgs. 42/2004 e il DPR 380/01. L’attuale DPR 380/01 è ormai obsoleto perché frutto di modifiche non coordinate che negli anni hanno cercato di fronteggiare alcune emergenze; un nuovo Testo è già incardinato nella discussione del CSLP nel quadro di una Legge delega del Parlamento; la Legge quadro, da cui discendono le norme tecniche– come sottolinea appunto Guzzoni - appare il luogo deputato a dare una soluzione possibile alle questioni poste al centro della giornata di lavori.
La già iniziata collaborazione tra MIT e MIC nella scrittura di una tale bozza legislativa è quella collaborazione che appare indispensabile e che potrebbe giovarsi dei contributi e dalle suggestioni di questa giornata di studi. È questo l’auspicio che l’ing. Guzzoni indica come base dei lavori e della discussione.
L’urgenza della tutela
Il Prof. Arch. Carlo Blasi ha presentato una proposta dettagliata volta a chiarire e migliorare le norme relative alla stabilità degli edifici tutelati. Ha messo in luce le difficoltà operative scaturite dalla distinzione tra sicurezza sismica e stabilità statica, e ha sottolineato l'importanza di un approccio educativo più approfondito nei percorsi universitari dedicati al restauro. Blasi ha evidenziato come la normativa attuale confonda le competenze e le responsabilità, spesso contrapponendo la conservazione alla sicurezza strutturale.
Illustrando la sua visione, ha affermato: "La legislazione tradizionale prevede che gli interventi, anche sismici, su beni tutelati siano sempre di competenza delle soprintendenze. Questo genera un contrasto tra conservazione e stabilità." Blasi ha proposto che nessuna norma tecnica debba essere cogente ma servire come riferimento, e che l'approvazione dei progetti dovrebbe essere unificata, con gli interventi realizzati da tecnici adeguatamente competenti.

Ha poi discusso le origini della confusione normativa, risalenti all'articolo 16 della legge sismica n. 64/1974, che ha separato la stabilità statica dalla sicurezza sismica, una distinzione che si è perpetuata in tutte le successive normative, incluso il Codice dei Beni Culturali. Blasi ha anche fatto riferimento alla sua esperienza nel restauro della cattedrale di Notre Dame e alla complicata gestione del palazzo di Teodorico per illustrare le problematiche legate alla ricostruzione post-sisma, sottolineando la necessità di una verifica della sicurezza e dell'assicurabilità dell'opera ricostruita.
Concludendo, Blasi ha letto le proposte della commissione mista MIT-MIBACT, enfatizzando la necessità di una maggiore integrazione delle competenze in materia di restauro nei percorsi di formazione universitaria, per superare le lacune attuali e garantire una gestione più efficace e sicura del patrimonio storico architettonico.
Sicurezza e Conservazione
Il convegno si è poi spostato sulla doppia necessità di garantire la sicurezza pubblica e la conservazione dei beni culturali, con interventi come quello del Prof. Ing. Antonio Borri e Arch. Anna Buzzacchi, che hanno discusso delle metodologie e delle sfide tecniche nel mantenere l'integrità strutturale pur conservando l'autenticità storica e culturale delle opere.
Il Prof. Antonio Borri ha trattato il delicato equilibrio tra la conservazione dei beni culturali e la sicurezza in zona sismica durante il suo intervento. Ha sollevato una questione fondamentale: "Viene prima la conservazione del bene o la sicurezza delle persone?" Sottolineando che la conservazione degli edifici non solo preserva il patrimonio, ma protegge anche le vite umane, ha evidenziato la frequente mancanza di interventi preventivi per la sicurezza statica su edifici storici danneggiati da terremoti. "Se non si fa prevenzione si raccolgono macerie," ha affermato, criticando la gestione corrente delle norme che, secondo lui, permetterebbero già una adeguata sicurezza se fossero interpretate correttamente e applicate efficacemente.

Borri ha messo in luce la carenza di competenze strutturali all'interno delle Soprintendenze e ha fatto riferimento agli eventi di Assisi come esempio di ciò che può succedere quando la sicurezza strutturale è trascurata. Ha ricordato come in passato si intervenisse attivamente sugli edifici storici inserendo catene, contrafforti e cerchiature per ridurne la vulnerabilità. Tuttavia, ha criticato l'approccio recente del Ministero della Cultura, che tende a limitare gli interventi sulle strutture murarie, spesso giustificando questa scelta con la necessità di preservare l'integrità visiva dei beni.
Borri ha anche sollecitato un rinnovamento dell'approccio regolamentare, citando l'esempio del testo di indirizzo richiamato nelle sue premesse dal presidente Sessa "Ma che fine ha fatto questo documento? Perché non è stato utilizzato e aggiornato? Occorre ripartire da questo testo," ha concluso, invitando a una riflessione sulle politiche attuali e sulla loro efficacia nella gestione del patrimonio culturale in contesti sismici.
L'arch. Anna Buzzacchi ha esplorato il tema della riduzione della vulnerabilità del patrimonio architettonico durante il suo intervento, enfatizzando la necessità di un approccio olistico nella gestione dell'architettura. "Nessun aspetto di un bene va privilegiato a scapito di altri," ha affermato Buzzacchi, sottolineando l'importanza di superare le divisioni tradizionali tra ingegneri e architetti per favorire un lavoro più integrato e multidisciplinare.

Ha messo in evidenza l'importanza di valutare le influenze del tempo sugli edifici, indicando che la conservazione dovrebbe tenere conto di tre principali aspetti: la funzionalità, la permanenza dei segni storici e la resilienza alle sollecitazioni ambientali e strutturali. Secondo Buzzacchi, è essenziale sviluppare una cultura della prevenzione piuttosto che limitarsi a interventi di restauro e ripristino post-danno.
Inoltre, ha discusso il potenziale della digitalizzazione nel settore del restauro, evidenziando come l'uso di modelli multirischio digitali possa essere cruciale per la prevenzione e la gestione dei rischi, migliorando così la sicurezza e la conservazione dei beni culturali. Questa visione si propone di armonizzare le esigenze di conservazione con le necessità strutturali, creando un quadro normativo che faciliti tali integrazioni.
Rischio e livello di esposizione
Edoardo Cosenza, Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha portato un contributo fondamentale alla discussione sul rapporto tra ingegneria strutturale e conservazione dei beni culturali, utilizzando il caso di Norcia come esemplificativo. Ha illustrato come gli interventi di messa in sicurezza realizzati dopo il terremoto del 1997 abbiano protetto la città, mentre la mancanza di adeguati rinforzi strutturali ha portato al crollo di diverse chiese storiche.
"L'esempio di Norcia ricordato dal Presidente e da Borri dimostra con urgenza la necessità di interventi strutturali adeguati," ha affermato Cosenza.
Durante il suo intervento, ha ringraziato il Presidente Sessa per l’impegno di prendere nuovamente in considerazione le Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.
Cosenza ha poi approfondito il concetto di esposizione, fondamentale nella gestione del rischio sismico relativo ai beni monumentali. Ha citato metaforicamente l'esempio di una piccola chiesa in un borgo isolato, che custodisce al suo interno un'opera d'arte storica di inestimabile valore: in questo caso l’esposizione non è calcolata sulla frequentazione ma sul valore del bene.

Tale contesto eleva notevolmente l'esposizione del bene, amplificando la necessità di una strategia di intervento ben definita che tenga conto sia del rischio umano sia della perdita culturale irreparabile. "È essenziale sviluppare linee guida specifiche per la classificazione del rischio di questi edifici storici, integrando l'esposizione e il valore storico artistico per stabilire priorità di intervento chiare e appropriate," ha concluso Cosenza, sottolineando l'importanza di un approccio olistico e rigoroso nella protezione del nostro patrimonio culturale in contesti sismici.
Giovanni Cardinale, progettista, ha posto l’attenzione su responsabilità e processi normativi. Nel merito ha sottolineato che la direttiva del MIC del 2011 ha una impostazione corretta ma richiama norme ormai superate da 15 anni e, soprattutto, non viene applicata nella sua parte più innovativa: sviluppare consapevolezze condivise tra committente e progettista e costruttore sul livello di rischio da assumere per coniugare tutela e sicurezza. Inoltre, partendo dalla riflessione sul determinismo delle tensioni ammissibili che, parzialmente rimosso dalle norme tecniche sin dal 2008, è ancora alla base della legge quadro (DPR 380/01 - art 64) ha suggerito proposte operative orientate verso una decisa innovazione normativa: una nuova legge quadro che tratti specificatamente anche dei Beni tutelati, introduca la categoria del “rischio” e indirizzi le nuove norme tecniche verso una separazione netta tra nuove costruzioni e costruzioni esistenti e, all’interno di questa parte, tra edifici ordinari ed edifici tutelati.

La progettazione deve proporre nuove soluzioni
L'intervento di Prof. Arch. Francesco Doglioni, esperto in restauro architettonico e prevenzione antisismica, ha evidenziato l'importanza di un approccio accurato alla conservazione del patrimonio architettonico storico, soprattutto in relazione ai danni sismici. Doglioni, con la sua esperienza maturata allo IUAV e nelle sue numerose ricerche sul campo, ha sottolineato la necessità di interpretare "l'insieme dei segni" come indicatori di fatica, danni o emergenti vulnerabilità delle strutture.
Durante il suo discorso, ha evidenziato come le linee guida del Ministero della Cultura (MIC) abbiano fornito un quadro di riferimento utile, ma spesso non adeguatamente integrato nelle normative tecniche vigenti. Ha citato in particolare le circolari del MIBACT del 2015, descrivendole come un passo avanti verso un programma più ampio di interventi che tengano conto della "conoscenza della fabbrica" e delle sue trasformazioni storiche.

Doglioni ha poi discusso le tendenze recenti verso l'uso di esoscheletri e altre strutture esterne che servono a ridurre la vulnerabilità degli edifici senza comprometterne l'aspetto estetico, come nel caso illustrato di tiranti mascherati da pluviali. Questi metodi dimostrano un cambiamento nella filosofia del restauro, che ora accoglie interventi visibili e semipermanenti quando necessari per garantire la sicurezza strutturale senza nulla togliere alla storicità e integrità visiva degli edifici.
In conclusione, Doglioni ha ribadito la necessità di un dialogo continuo tra le prassi di restauro e le esigenze strutturali, sottolineando che la conservazione del patrimonio architettonico non può prescindere da una solida comprensione e gestione del rischio sismico.
La conoscenza approfondita delle strutture storiche
L’ ing. Paolo Iannelli, rappresentante del MIC, ha focalizzato il suo intervento sulla preservazione del valore identitario degli edifici tutelati, sottolineando la necessità di rispettare standard di sicurezza e d’uso accettabili. Iannelli ha affermato che l'approccio alla normativa e alla pratica del restauro richiede un profondo cambiamento culturale e non può basarsi solamente su titoli di studio ma deve essere fondato su competenze concrete.
"Abbandonare le norme deterministico prescrittive e pensare in modo più olistico è essenziale," ha detto Iannelli. A volte gli interventi eseguiti hanno poi provocato danni maggiori.
Ha illustrato ad esempio come la caduta della torre campanaria della basilica di San Benedetto, trattata come un blocco unitario, abbia causato danni significativi, dimostrando l'importanza di considerare le vulnerabilità specifiche di ciascun edificio.

Iannelli ha evidenziato l'importanza di una conoscenza approfondita delle strutture storiche. "Se non si conosce cosa si nasconde dietro l'intonaco, non si può sapere come intervenire correttamente," ha osservato. Ha sottolineato che nei beni culturali, il processo di restauro deve adattarsi durante l'esecuzione del progetto, poiché raramente la fase iniziale del progetto è perfetta.
L'ingegnere ha anche parlato dell'importanza della funzione pubblica nella gestione dei beni culturali, che non possono essere semplicemente chiusi o abbandonati perché non rispondono agli standard usuali. Ha proposto di considerare l’esperienza svolta nell’ambito della sicurezza antincendio come modello per superare le normative eccessivamente rigide, adottando un approccio ingegneristico che possa integrare soluzioni equivalenti adatte alle peculiarità dei beni culturali.
Infine, Iannelli ha richiamato l'attenzione al portale SecurArt, il sistema per la gestione delle informazioni tecniche e gestionali relative al patrimonio immobiliare del Ministero della Cultura
Il seminario si è concluso con un dibattito vivace, coordinato dall ing. Andrea Dari, seguito dalle conclusioni dell’ ing. Donatella Guzzoni, che ha ribadito l'importanza di un approccio che integri conoscenza tecnica, sensibilità culturale e consapevolezza storica nella gestione del patrimonio costruito.
Questo incontro ha evidenziato una crescente consapevolezza della necessità di adottare un approccio multidisciplinare che vada oltre le norme esistenti per proteggere e valorizzare il patrimonio storico in maniera sostenibile e rispettosa delle sue intrinseche valenze culturali e sociali.
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA INTEGRALE DELL'EVENTO.

Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Normativa Tecnica
Con questo TOPIC raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano il tema della normativa tecnica: le nuove disposizioni, le sentenze, i pareri e commenti, l’analisi di casi concreti, il commento degli esperti.

Restauro e Conservazione
Con il topic "Restauro e Conservazione" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati che esemplificano il corretto approccio a quel sistema di attività coerenti, coordinate e programmate, dal cui concorso si ottiene la conservazione del patrimonio culturale.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp